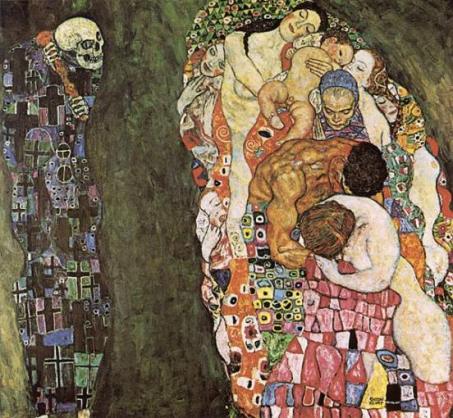
L’Io Nudo
di Piero Priorini
(tratto dal libro MALDAFRICA)
Dopo tanti anni di ricerca psicologica e psicanalitica, di esperienze cliniche e di verifiche comparative, era inevitabile che qualcuno – prima o poi - tentasse di rintracciare e teorizzare l’esistenza di una matrice comune ai tanti disagi psichici di cui l’uomo ha sempre sofferto. Una sorta di nucleo originario dal quale sarebbero poi scaturite, per differenziazioni basate sull’infinito numero delle variabili costituzionali ed ambientali, tutte le sindromi fino ad oggi conosciute.
Una delle teorie più accreditate – in tal senso - sarebbe quella che individua tale matrice nell’angoscia che ci deriverebbe dall’essere coscienti della nostra condizione di creature mortali In effetti, in quanto uomini, noi siamo gli unici esseri viventi ad essere consapevoli della fine ineluttabile verso la quale procede la vita, e questa consapevolezza – a lungo andare, nel corso dei millenni – potrebbe aver creato il terreno per una sorta di Angoscia Ontologica su cui poi tutte le altre nevrosi affonderebbero le loro radici.
Potrebbe darsi… chiunque di noi terapeuti abbia lavorato a lungo sul campo, prima o poi, in fondo al pozzo oscuro dell’anima della maggior parte dei suoi pazienti, ha visto spuntare l’orrore per la morte. Una sorta di panico assoluto che, come una “Santa Barbara“ psichica, sembra sempre sul punto di esplodere al benché minimo urto.
Potrebbe darsi… la teoria non mi è mai sembrata del tutto infondata… semmai imprecisa o, meglio ancora, incompleta.. Perché dato il fatto che comunque non tutti gli uomini presentano una tale angoscia di fondo, e a meno di non voler considerare questa mancanza il risultato di una rimozione o di una negazione (sappiamo tutti che la psicanalisi, spesso, è auto-referenziale e tende a vedere nevrosi dietro qualunque manifestazione umana), piuttosto dovremmo chiederci:
- Perché per molti uomini la consapevolezza più o meno latente della propria morte genera una angoscia incontrollata? Cosa differenzia queste persone da tutte le altre che, pur conoscendo il proprio ineluttabile destino di creature mortali, in un qualche modo tentano di penetrarne il significato? Cosa li differenzia da tutti quelli che comunque, in un qualche modo, riescono a sciogliere l’enigma della morte all’interno del mistero stesso della vita?
Possibile che la potenzialità di consapevolezza che in quanto uomini vantiamo sia una malattia? E, conseguentemente, che l’unico modo per vivere bene sarebbe allora quello di rimuoverla alla radice? Possibile che tutto ciò che abbiamo prodotto nell’arte, nella religione e nella scienza in più di 10.000 anni di storia non sia altro che il risultato di una copertura?
In tutta onestà… mi sembrano questi pensieri claudicanti.
Però una cosa è certa: molti uomini e donne moderni, sotto uno strato di sintomi i più disparati, nascondono una base di angoscia esistenziale la cui origine è possibile far risalire all’angoscia di morte.
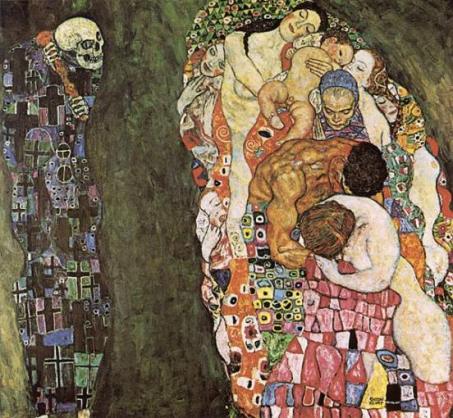
Questa estate ero in viaggio, insieme alla mia compagna… avevamo attraversato buona parte dello Zambia ed eravamo entrati nel Lower Zambesi National Park. Un pomeriggio affittammo un motoscafo e ci facemmo trasportare sulle acque del grande fiume: pullulava di coccodrilli e di ippopotami che – come tutti sanno – sono, tra tutti gli animali selvaggi, i più pericolosi in assoluto. Figuratevi perciò il nostro stupore nell’incontrare ogni tanto misere piroghe, ricavate da tronchi d’albero scavati, sulle quali gli autoctoni se ne andavano a pesca sospingendosi con delle lunghe pertiche. Se paragonata alla nostra, la loro velocità di fuga in caso di attacco improvviso da parte di questi animali che stazionano sott’acqua, e sono perciò invisibili, era risibile.
Chiesi perciò alla nostra guida:
- Ma non è pericoloso?
Mi guardò sereno e senza la più piccola affettazione mi rispose:
- Certo… ogni tanto qualcuno non torna. È normale… è la vita… il ciclo della Vita.
Il nostro motoscafo solcava veloce le acque incendiate dal sole che andava tramontando. La bellezza del fiume era struggente e io ero senza fiato. Non solo per lo spettacolo che si dispiegava ai miei occhi, ma anche per le parole della nostra guida che si incidevano a fuoco nella mia anima.
- E’ il ciclo della Vita… è normale… ogni tanto qualcuno non torna…
Avevamo già altre volte verificato l’estrema semplicità con cui la maggior parte degli africani si percepisce inserita nel ciclo della natura e, senza drammatizzare più di tanto, ne accetta le estreme conseguenze. Ma l’impatto con l’austerità del loro sentire non era mai stato così violento. Perciò, da buon occidentale raziocinante, mentre con una parte di me stesso mi abbandonavo alle intense emozioni che il tramonto sulle acque dello Zambesi mi stava regalando, con un’altra parte andavo elaborando una concatenazione di pensieri che, speravo, mi avrebbe permesso di penetrare e comprendere i motivi della differenza di atteggiamento con cui gli occidentali moderni e gli africani si relazionano al tema della morte. Perché intuii subito che quel diverso atteggiamento non era una semplice divergenza culturale, bensì l’effetto finale del lungo e tortuoso processo evolutivo che separa le due civiltà.
“Quando nuotavo nel grembo di mia madre – racconta un anziano - ero sereno e tranquillo, e non avrei mai voluto attraversare la porta che mi avrebbe introdotto alla vita terrena.
Anche quando ero bambino ero felice e non avrei mai voluto superare la porta che mi avrebbe condotto alla responsabilità degli adulti.
Poi fui guerriero, e mi addolorò varcare la porta che mi condusse al matrimonio.
Ora sono un anziano e penso che la morte sarà un’altra porta da attraversare per continuare il mio cammino…”
Queste le parole di un vecchio africano.
Non intendo minimamente privarle del loro valore originale attribuendogli un significato diverso (per esempio consolatorio, fideistico o di copertura) da quello che, invece, di fatto palesano. Le prendo per quelle che sono e mi chiedo: quali sono gli elementi che permettono alla maggior parte degli africani di stabilire un rapporto così sereno con la morte?
La risposta è semplice e, in un certo senso, potrei dire di averci girato intorno fin dalle prime pagine di questa raccolta: l’uomo, in Africa, per tutta una serie di circostanze (che vanno dall’estrema crudezza delle condizioni di vita in un ambiente severo e selvaggio, ad una sorta di costituzionale sensibilità interiore), di fatto, è come se avesse arrestato il proprio processo evolutivo. È rimasto fermo in illo tempore – come avrebbe detto M.Eliade – al “Tempo delle Origini”, in comunione profonda con la natura e con gli esseri elementari che la animano. In un simile contesto gli “Dei hanno continuato a parlare” alla sua anima e hanno fissato per lui, una volta per tutte, le mete interiori ed esteriori da perseguire momento per momento… affinché non dovesse perdersi. La vita dell’uomo in Africa è sempre stata scandita – almeno fin’ora, anche se ancora per poco – da rituali iniziatici che, essendo fondati sulla percezione del sacro, immettono l’individualità in una dimensione esistenziale e in un ruolo che mai più nessuno oserà mettere in discussione. Come già altrove ho accennato, qua e là, nei vari articoli, il rituale iniziatico non testimonia un avvenuto cambiamento naturale, non accompagna o sancisce i mutamenti di condizione, non assolve ad una mera funzione coreografica, ma è un vero e proprio atto creativo. Esso genera un’altra realtà: qualcosa, che prima non esisteva, dopo il superamento della prova comincia ad esistere. Così, e solo così, vengono costituiti e determinati i vari status sociali individuali i quali, non avendo nulla a che vedere con quelli biologici-naturali, sono vissuti come un attestato insindacabile della progressiva maturazione degli individui.
“Questo itinerario ideale – ha scritto la psicanalista A.Lamonica1 a proposito dei riti iniziatici – ha consentito, sin da tempi remotissimi, l’acquisizione di condizioni non più legate a fattori di maturazione esclusivamente fisiologica, ma anche ontologica e spirituale.” Passaggi di status che hanno finito per assumere una importanza centrale, non solo per l’individuo iniziato, grazie all’attivazione e all’incanalamento positivo delle sue energie e capacità; ma anche per la comunità (che del resto ha predisposto i rituali stessi), compiendo una azione rigenerativa (in quanto vi è afflusso di forze nuove e positive) e un’azione normativa e coesiva.
In un siffatto contesto culturale, la società, il gruppo tribale, la famiglia, hanno un ruolo centrale.
Ogni nuovo individuo, infatti, fin dal momento del proprio concepimento, e poi per tutta la durata della gestazione, si sperimenta - al livello proto-emozionale - desiderato ed accolto come parte integrante del contesto umano nel quale svolgerà la propria vita; e questo sentimento di unione e appartenenza gli rimarrà impresso, in maniera indelebile, fino all’ultimo respiro.
Al momento della nascita, poi, anziché essere strappato e allontanato dall’organismo materno all’interno del quale si è formato, molto più naturalmente ne diventa una appendice esterna, soggiornando sul corpo della madre all’incirca per altri tre anni. Almeno fin tanto che una naturale e spontanea curiosità nei confronti del mondo che lo circonda lo porterà ad allontanarsi progressivamente da lei. Troverà allora un contesto collettivo di Madri a tutti gli effetti che continuerà a vigilare su di lui, accompagnandolo con discrezione in questo processo di progressiva presa di coscienza di sé. La “famiglia allargata” africana non è un concetto astratto. Piuttosto è una presenza reale e concreta all’interno della quale c’è una collocazione per ogni singolo individuo.
Più tardi, alla morte dell’infanzia e con l’ingresso nella vita adulta, sia per gli uomini che per le donne cominceranno le prove di coraggio e di solitudine che sanciranno l’avvenuta maturazione interiore. Ma, a ben vedere, tutte queste prove si svolgono su uno sfondo di solidarietà e di coesione immutabile. La tribù, il gruppo, il clan, la famiglia sono sempre lì, come certezze perenni a cui si può tornare a far riferimento in un qualunque momento. Anche la solitudine del guerriero è relativa; perché è alimentata dalla stima, dal rispetto, dal riconoscimento del ruolo che nessuno si sognerebbe mai anche soltanto di mettere in discussione. Neanche la solitudine dell’anziano è assoluta, perché sostenuta dagli obblighi sacri a cui lo stesso deve assolvere: l’anziano, infatti, è il depositario delle storie, dei canti, dei gesti e delle immagini nelle quali è racchiusa la tradizione e, come suo testimone, è chiamato a comportarsi.
Mi rendo conto di essere stato fin troppo sintetico, ma in sostanza quello che voglio sottolineare è che l’Io profondo di ogni singola individualità africana, per il contesto ambientale e culturale in cui almeno fin’ora ha realizzato la propria esistenza, non è mai arrivato a sviluppare quella totale e assoluta separazione dal mondo della natura e dal contesto sociale che invece, nel bene e nel male, rappresenta la caratteristica precipua dell’Io dell’uomo moderno occidentale.
Facciamo un confronto: e sorvolando sulla natura più profonda dei veri motivi che possono portare una donna e un uomo moderni a concepire una nuova vita (perché altrimenti ne sentireste delle belle), cominciamo ad osservare il momento della nascita. La rottura delle acque, il taglio del cordone ombelicale, l’invasività della luce artificiale della camera operatoria, se tutto va bene pochi minuti di rassicurazione sul corpo di cui, fino a pochi secondi prima, si era parte integrante… poi la separazione, asettica, nella nursery dell’ospedale.
Pochi minuti dopo aver abbandonato le Grandi Acque, l’Io dell’uomo moderno occidentale è già irrimediabilmente solo, separato, scisso, costretto a fare di se stesso un punto di riferimento nel caos sensorio ed emozionale che lo circonda. Né la cosa migliorerà una volta giunto tra le mura della stanza che, per un tempo indefinibile, rappresenterà la sua dimora. Nel migliore dei casi le sue  necessità elementari, i suoi bisogni, i suoi dolori, le sue paure potranno essere ben interpretate e amorosamente alleviate… ma non empaticamente condivise e partecipate. La donna moderna (pur con le dovute eccezioni) ha perduto l’istinto profondo della maternità. Ho già descritto, nel primo articolo di questa raccolta, i motivi e le ragioni di questa perdita, e non vorrei perciò ripetermi. Mi basta qui sottolineare come già fin dai primissimi giorni l’esperienza profonda, pre-verbale, del nucleo interiore dell’uomo e della donna moderni occidentali sia infinitamente diversa da quella che, almeno fin’ora, ha caratterizzato gli africani.
necessità elementari, i suoi bisogni, i suoi dolori, le sue paure potranno essere ben interpretate e amorosamente alleviate… ma non empaticamente condivise e partecipate. La donna moderna (pur con le dovute eccezioni) ha perduto l’istinto profondo della maternità. Ho già descritto, nel primo articolo di questa raccolta, i motivi e le ragioni di questa perdita, e non vorrei perciò ripetermi. Mi basta qui sottolineare come già fin dai primissimi giorni l’esperienza profonda, pre-verbale, del nucleo interiore dell’uomo e della donna moderni occidentali sia infinitamente diversa da quella che, almeno fin’ora, ha caratterizzato gli africani.
Ma non basta: perché gli usi e i costumi della nostra società invitano le famiglie ad allontanare prima possibile i bambini dal nucleo familiare. Gli asili nido prima (a volte già ad un anno) e la scuola materna poi, vengono abilmente giustificate come una salutare, precoce socializzazione del bambino che, a lungo andare, porterà i suoi frutti.
Bhé… posso solo dire che nonostante mi ritenga oramai assuefatto alle colossali stupidaggini che il pensiero moderno, cerebrale e astratto, riesce a partorire, questa della precoce socializzazione dei nostri bambini riesce ancora a farmi andare su tutte le furie: ma come si può essere così ciechi? Come si può essere così stupidi? Non credo che riuscirò mai davvero a comprenderlo.
Come che sia… non sento di dover sprecare troppe parole per evidenziare come, nella precoce scolarizzazione, il processo di scissione e separazione dell’Io si vada accentuando e consolidando, gettando le basi per tutte quelle forme di asocialità che caratterizzano il nostro mondo.
La scolarizzazione precoce, infatti, anticipa di molto quel processo di centroversione che sarebbe dovuto iniziare solo dopo i sette anni, con l’istruzione elementare. Perché è appunto l’istruzione scolastica che, sollecitando le facoltà logiche e astratte dell’uomo, assolve al compito di svincolarlo e separarlo definitivamente dal mondo della natura. Da quella comunione intima e profonda che è si originaria, ma nella quale solo l’innocenza corticale permetterebbe di rimanere.
A questo proposito rimando ancora una volta il lettore eventualmente interessato al bellissimo libro autobiografico di Mano Dayak2: “Sono nato con la sabbia negli occhi”. L’autore – scomparso da alcuni anni in un incidente aereo – era un Tuareg originario dell’Air che ebbe la fortuna (o forse la sfortuna) di ricevere prima gli insegnamenti magico-visionari grazie ai quali il suo popolo era sopravvissuto tra le sabbie del Sahara; e subito dopo – costretto ad ottemperare agli obblighi scolastici con i quali il governo colonialista francese intendeva piegare la ribellione tuareg – li vide indebolirsi e infine scomparire per sempre dalla propria anima. Il libro contiene alcune delle pagine più interessanti che siano mai state scritte sulla incompatibilità tra conoscenza immaginativa (che è una vera e propria forma di conoscenza della realtà) e la conoscenza intellettuale (che ne rappresenta invece un’altra). Ciò che fa la differenza tra le due è la condizione di parziale fusione dell’Io con il mondo, in un caso, e di totale scissione nell’altro.
Insomma… quello che intendo dire è che, mentre l’uomo africano, sempre per tutta una serie di motivi, ha mantenuto una esperienza di “sé nel mondo” ancora coesa ed armonica, così che il senso e il significato della propria individualità unica e irripetibile è ancora relativo, l’uomo moderno occidentale, al contrario, ha vissuto in pieno la separazione e percepisce perciò l’assoluta solitudine del proprio Io. È quello a cui accennavo nelle prime pagine di questa raccolta quando individuavo nella “percezione dell’Io nel pensiero” (il: cogito, ergo sum di Descartes), e nell’avvenuta frattura (divenuta poi insanabile) tra la res cogitans e la res extensa, il traguardo straordinario a cui la civiltà moderna occidentale ha condotto la maggior parte dei suoi figli.
Ogni epoca, ogni civiltà ha contribuito a farci raggiungere questo risultato, perfezionando facoltà dell’anima via via sempre diverse. Preparando l’Io umano al momento della grande prova.
Questo sarebbe il momento tanto atteso: la civiltà occidentale ha operato un sforzo titanico ed è riuscita a isolare l’Io dell’uomo da tutto ciò su cui prima si fondava. Gli Dei hanno smesso di parlare; la stessa Natura, violentata e abusata in tutti i modi possibili, progressivamente è divenuta muta; il sentimento sociale di appartenenza è diventato relativo; la famiglia si è sbriciolata sotto l’incalzare di bisogni e “diritti” egoistici che fino a qualche generazione fa venivano invece in un qualche modo contenuti. Quel poco che resta di tutto ciò quasi sempre è convenzionale, borghese (nel senso peggiore del termine), non autentico, esteriore, falso… comunque relativo nel tempo. Non a caso siamo una società di Singoli, uomini e donne soli che pur fantasticando chissà quale realizzazione romantica, inseguono soltanto l’affermazione dei propri bisogni solipsistici.
Tuttavia, in sé e per sé, questo stato di cose, lungi dal rappresentare una aberrazione evolutiva, avrebbe dovuto essere propedeutico alla realizzazione di una più autentica libertà. Temprato infatti dalla propria assoluta, totale solitudine e libero da costrizioni morali, religiose e sociali di qualunque natura, l’uomo moderno – come forse ho ripetuto già fin troppe volte – si sarebbe dovuto trovare ora nella condizione di operare le sue scelte guidato esclusivamente dalla propria Fantasia Morale. Nudo e solo, signore assoluto dei propri cieli, padrone indiscusso delle forze che governano la vita di questo pianeta, attore protagonista o, se vogliamo, principale interprete del proprio destino, l’uomo moderno avrebbe dovuto cominciare a muoversi guidato da un rinnovato rispetto e un ritrovato amore verso la Vita del pianeta e di tutti coloro che lo abitano. Non più soggetto ad alcuna legge, avendo accolto e radicato nella propria anima il Principio Vivente da cui ogni legge proviene.
Ma come spesso accade, il diavolo ci ha messo lo zampino, inasprendo quelle condizioni già durissime all’interno delle quali l’Io dell’uomo moderno avrebbe dovuto comunque maturare e svilupparsi. Ha moltiplicato le difficoltà che l’Io avrebbe dovuto superare per arrivare a percepirsi fondato in sé stesso e, per libera scelta, capace di trascendersi. Madri anaffettive, assenti, distratte o, invece, possessive e invadenti; padri latitanti, irresponsabili, deboli oppure seduttivi o, peggio ancora, violenti; insegnanti incapaci, indifferenti, stupidi a volte e altre volte arroganti; modelli sociali distorti, falsi, irraggiungibili, superficiali… Molti non ce la fanno. Alla fine della delicata fase evolutiva l’Io dell’uomo moderno occidentale il più delle volte arriva non solo nudo bensì anche denutrito. Ma senza “calore interno” è impossibile resistere al gelo siderale della solitudine. Senza riserve di energia interiore il “corpo dell’Io” è inerme di fronte al “vuoto” del cosmo.
“Perché l’identità – ci ricorda U. Galimberti3 nel suo saggio: L’ospite inquietante – si costruisce a partire dal riconoscimento dell’altro.”
Per questo l’Io dell’uomo moderno occidentale, privato dell’alimento d’amore indispensabile per consolidare la propria struttura interiore, impossibilitato a rintracciare motivi di stupore, fiducia ed entusiasmo nell’ambiente umano che si occuperà della sua educazione, arriva denutrito, gracile e asfittico al momento della verità. Quando, potendo contare solo sulle proprie forze, dovrebbe poter sfidare l’anonimato sociale a cui sembra destinato, impegnarsi contro il futuro-minaccia che oramai gli si para di fronte (mutamenti ecologici, carenze energetiche, crolli economici, guerre devastanti), e credere invece nell’illimitata potenziale libertà di cui la sua più intima natura si sostanzia.
Come dicevo, molti non ce la fanno.
In questa dinamica è racchiuso il crollo della civiltà occidentale. Bisognava osare il tutto e per tutto per denudare l’uomo ed esporlo così, senza più sostegno alcuno, al cospetto del mistero non ancora svelato della propria natura. Bisognava osare molto… ma la verità – almeno questa è la mia convinzione – è che egli non era ancora pronto. La verità è che è stato spinto con l’inganno, troppo presto, ad andare oltre le proprie forze… gli ostacoli, i blocchi, le opposizioni che ha incontrato sono stati tali, e così grandi, da non lasciargli altre alternative possibili se non la chiusura rigida a difesa della propria vulnerabilità, lo sviluppo compensatorio di un’immagine grandiosa di sé e, per finire, il perseguimento di obbiettivi tanto più inutili quanto più superficiali.
Il risultato è che l’occidente si è come ripiegato sotto l’immenso sforzo operato, e l’ego dei suoi figli, anziché aprirsi allo spirito, si è invece ulteriormente chiuso ed indurito.
Divenendo, come il diamante, solitario, freddo, inaccessibile e inattaccabile… da tutto e da tutti… ma non da ciò che ineluttabilmente si pone come la negazione del suo stesso esistere. La Morte, appunto, come svalutazione irrisoria di ogni sforzo profuso, come vanificazione di ogni traguardo raggiunto; la morte come insulto, come oltraggio, come ingiuria che spazza via alla radice la più piccola pretesa di affermazione narcisistica di sé.
In un simile contesto apparirà forse ora evidente l’abisso che separa l’esperienza esistenziale dell’uomo africano da quello occidentale. Anche nel momento cruciale della propria morte l’uomo africano non è mai davvero solo: la Tradizione, che lo ha guidato nel corso della vita, lo protegge ora, nel momento dell’estremo commiato. Intorno a lui la “famiglia allargata” e l’intera tribù rappresentano un sostegno solido e consistente. Oltre la soglia gli Antenati lo attendono per iniziarlo alla nuova vita. Non c’è panico. Non c’è orrore, perché non c’è un Io totalmente autonomo e indipendente che possa sperimentarlo.
Non è così per tutti noi occidentali: perché ognuno di noi, nel bene e nel male, ha dovuto combattere per essere se stesso, pur senza riuscirvi compiutamente ogni volta. Anzi… la storia di ognuno di noi potrebbe essere immaginata come un susseguirsi di vittorie e sconfitte all’interno delle quali ci siamo più volte trovati e poi perduti, e poi ancora ritrovati e poi ancora perduti… Per sopravvivere ci siamo dovuti indurire, chiudere in noi stessi, affermare la nostra originalità assoluta e, come conseguenza, arriviamo impreparati al momento in cui, per scoprire la nostra natura ultima, dovremmo rinunciare a tutto ciò su cui fino a quel momento ci eravamo appoggiati.
Questa è la risposta alle domande poste all’inizio di questo articolo: più duro è l’Io, più grande il panico. Più tensione esercita per essere, più angoscia sperimenta per divenire.
La soluzione a questo male profondo che ci affligge, tuttavia, non riposa in Africa, indietro nel tempo, bensì nel coraggio di proseguire ciò che abbiamo solo iniziato. Perché – come scrisse H.Hesse4 nel suo libro visionario “Il lupo della steppa”:
“ Non vi è strada che porti indietro, né al lupo né al fanciullo. In principio non vi è innocenza né semplicità: tutto ciò che è creato, anche le cose apparentemente più semplici, sono già colpevoli, sono già molteplici, buttate nel sudicio fiume del divenire e non possono mai più, mai più risalire la corrente. La via verso l’innocenza, verso l’increato, verso Dio non è un ritorno ma un proseguire, non porta verso il lupo o il fanciullo, ma sempre avanti nella colpa, sempre più addentro nel divenire dell’uomo. Il ritorno al tutto, l’annullamento della dolorosa individuazione, il divenir Dio significa aver allargato talmente la propria anima da poter riabbracciare l’universo.”
Per contatti: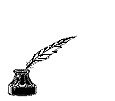 - vai alla Home
- vai alla Home ![]() Facebook
Facebook ![]()